Narrazioni contrapposte: tra storia e trasformazioni urbane.
Giuliana Barletta
Borgata Vittoria e Madonna di Campagna costituiscono una parte di città che è stata frequentemente oggetto di narrazione da parte del giornale La Stampa. Le tematiche che evincono maggiormente trattano di cronaca nera[1], inquinamento[2] e trasformazioni urbane[3]. Meno evidenti ma comunque rintracciabili sono i temi di viabilità, politica, società, eventi, tradizioni e cultura. Il racconto sembra vincolato, tuttavia, soprattutto alla microcriminalità, al senso di pericolo e degrado trasmesso dallo spazio urbano e dalla fatiscenza degli edifici. “Manette per un giovane spacciatore. (…) sorpreso nei pressi della sua abitazione in corso Grosseto” riporta uno dei tanti articoli che si riscontra tra le pagine1. La percezione è alquanto negativa e, con questi toni poco lusinghieri, tali quartieri tornano tra le righe citati come sfondo di spaccio, reati, incidenti e furti.
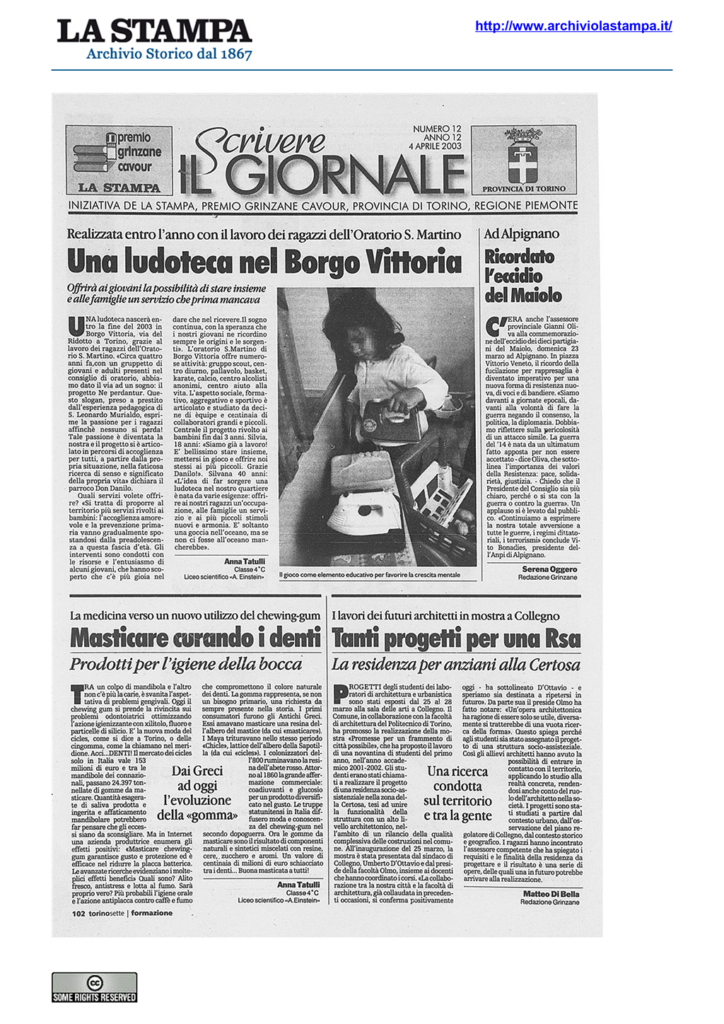
Eppure, questa narrazione non ne esaurisce la loro complessità. Borgata Vittoria è un quartiere vivace e ricco di storia. Tra gli articoli si colgono anche iniziative culturali[4], rievocazioni storiche della battaglia di Torino del 1706 tra i francesi e i sabaudi, spettacoli teatrali, musica, itinerari guidati a cura del Centro di Documentazione storica della Circoscrizione 5, mercati rionali e manifestazioni. L’articolo del 4 aprile 20035 parla dell’apertura di una ludoteca, quale spazio per offrire ai giovani la possibilità di stare insieme e ai genitori un servizio che prima mancava; l’articolo del 24 ottobre 20044 presenta il progetto “Un territorio si racconta 1706-2004”, con spettacoli, musica e mostre negli spazi della Circoscrizione 5. La storia di questi quartieri è segnata da profonde trasformazioni urbane. Un articolo del 1972 documenta l’allargamento di corso Grosseto3:
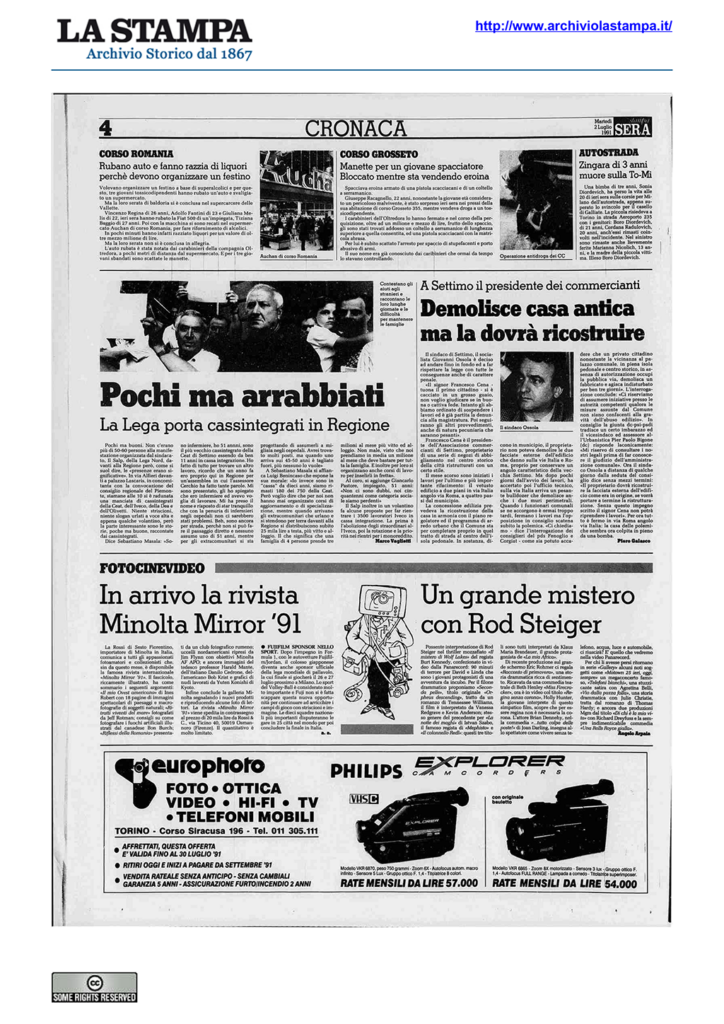
«Per allargare corso Grosseto sradicati 350 platani. Le piante sono destinate ad altre aree verdi. (…) Il provvedimento è stato preso dal Comune per consentire l’ampliamento della carreggiata centrale in modo da sopportare un aumento di traffico (…)».
L’intervento ha modificato radicalmente l’aspetto dell’asse stradale: da vialone centrale con aiuole e spazi verdi, dove i bambini giocavano e le persone si intrattenevano, si è giunti ad una conformazione urbana dominata da grandi carreggiate ad alto scorrimento, che si sono configurate come una barriera urbana per il pedone. L’urbanizzazione crescente ha portato poi l’attenzione su nuovi problemi, come documentato nell’articolo del 12 maggio 19952, che denuncia il forte inquinamento acustico e atmosferico del cavalcavia di Corso Grosseto:
«Il cavalcavia di Corso Grosseto è uno dei punti più rumorosi di Torino. (..) Che ci sia bisogno di proteggere i residenti degli edifici in prossimità dei cavalcavia è evidente. Basta alzare gli occhi sui caseggiati. Anneriti dal fumo. E il rumore è assordante, specie per i primi piani.» Si è pensato, dunque, all’inserimento di barriere antirumore e Corso Grosseto è diventata un laboratorio di sperimentazione per il Comune. Ma l’articolo che più di tutti testimonia e sintetizza il processo trasformativo che ha riguardato questo frammento di città è quello dell’11 ottobre 1991 intitolato: “In Borgo Vittoria la campagna fu sconfitta”[5], che commenta l’urbanizzazione di Borgo Vittoria dal 1706, anno della battaglia di Torino tra francesi e sabaudi, al Dopoguerra, che vide lo sviluppo di un programma di espansione urbana per far fronte alla crescente domanda abitativa. Nel 1853, in particolare, Borgo Vittoria era ancora una zona prevalentemente agricola, caratterizzata da campi e cascine. Lo scenario, d’altronde, non era molto diverso da quello del 1706. Tuttavia, su quei terreni si stava per combattere un’altra battaglia: quella tra il progresso industriale e il verde agricolo. Nel corso del Novecento, infatti, la campagna cedette il passo all’industria e così, al paesaggio delle cascine, si aggiunsero i primi edifici a più piani, destinati alla classe operaia. Oggi, le tracce di quel passato rurale sono visibili in strade come via Montesoglio, via Tesso e via Mondrone. La periferia del quadrante nord di Torino è, quindi, da sempre stata un’area mutevole, reattiva alle sollecitazioni ed alle trasformazioni, non uno spazio immutevole e di immutata fragilità sociale e urbana. Ancora oggi, dunque, può costituire la miccia per dinamiche spinte di cambiamento e rigenerazione, trascendendo le modalità di racconto, positive o negative che siano, che l’hanno riguardata negli anni.

Bibliografia
1 Stampa Sera 02/07/1991 – numero 144 pagina 4
2 La Stampa 12/05/1995 – numero 125 pagina 39
3 Stampa Sera 04/03/1972 – numero 54 pagina 4
4 Torino Sette 24/09/2004 – numero 802 pagina 41
5 Torino Sette 04/04/2003 – numero 730 pagina 102
6 Stampa Sera 11/10/1991 – numero 228 pagina 18
Fonti archivistiche
Archivio La Stampa, Torino.
[1] Stampa Sera 02/07/1991 – numero 144 pagina 4
[2] La Stampa 12/05/1995 – numero 125 pagina 39
[3] Stampa Sera 04/03/1972 – numero 54 pagina 4
[4] Torino Sette 24/09/2004 – numero 802 pagina 415
[5] Torino Sette 04/04/2003 – numero 730 pagina 102
[5] Stampa Sera 11/10/1991 – numero 228 pagina 18
